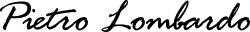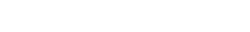“Chi nella propria vita si è sempre protetto dalle esperienze di dolore, non potrà offrire agli altri che una vuota consolazione” H. Nouwen
 Il dono della vulnerabilità è ciò che ci permette di incamminarsi verso la strada della realizzazione personale. Che cosa significa vulnerabilità? Significa (deriva dal latino “vulnerare” derivato di “vulnus-eris”, “ferita”) propensione ad essere feriti. Se per diventare invulnerabili ci chiudiamo nei nostri rigidi sistemi di difesa, corriamo il rischio di rinunciare all’amore, all’incontro della vera amicizia, al ricevere aiuto e consolazione. Rendersi vulnerabili significa sapere che la sofferenza fa parte del cammino umano. Colui che ama veramente è disponibile a venir ferito, perché aprirsi nella nudità dell’essere se stessi è il dono più grande che possiamo fare al prossimo. Le ferite ci spingono a costruire delle corazze, a soffocare la parte più debole e fragile di noi, nascondendola accuratamente al fine di proteggerla. Così facendo è come se ci sedessimo a trattenere il respiro nella notte del dolore, respingendo il chiarore di un’alba colma d’amore e di nuovi orizzonti.
Il dono della vulnerabilità è ciò che ci permette di incamminarsi verso la strada della realizzazione personale. Che cosa significa vulnerabilità? Significa (deriva dal latino “vulnerare” derivato di “vulnus-eris”, “ferita”) propensione ad essere feriti. Se per diventare invulnerabili ci chiudiamo nei nostri rigidi sistemi di difesa, corriamo il rischio di rinunciare all’amore, all’incontro della vera amicizia, al ricevere aiuto e consolazione. Rendersi vulnerabili significa sapere che la sofferenza fa parte del cammino umano. Colui che ama veramente è disponibile a venir ferito, perché aprirsi nella nudità dell’essere se stessi è il dono più grande che possiamo fare al prossimo. Le ferite ci spingono a costruire delle corazze, a soffocare la parte più debole e fragile di noi, nascondendola accuratamente al fine di proteggerla. Così facendo è come se ci sedessimo a trattenere il respiro nella notte del dolore, respingendo il chiarore di un’alba colma d’amore e di nuovi orizzonti.
Prendere coscienza delle proprie ferite
Cosa accade se non si prende contatto con le proprie ferite? Innanzitutto vengono negate (“io non ho problemi”) o rifiutate (“vade retro sofferenza”). Ciò ha delle conseguenze pesanti nei rapporti interpersonali, soprattutto nella sfera affettiva. Ad esempio, ci si può presentare davanti ad una persona nella convinzione che si è sempre nel giusto, mentre è l’altra che ha dei problemi: io sono a posto e l’altro deve cambiare. In secondo luogo, si arriva alla convinzione di non avere bisogno di essere aiutati, di poter contare unicamente sulle proprie risorse intellettive o sulla propria forza di volontà. Questo atteggiamento di negazione porta ad attuare un sistema di ipervigilanza mentale, che può diventare controllo ossessivo (spesso a livello inconscio) sulla propria e altrui vita. Chi non sa riconoscere le proprie ferite farà di tutto per tenerle lontane, per evitare di essere toccato nella sua parte più sensibile e dunque, in diverse modalità, tenterà di porre ad una certa distanza ogni evento che potrebbe rievocare situazioni analoghe. Questo crea uno stato di tensione interna che con il passare degli anni potrebbe sfociate in crisi di panico o in forti stati d’ansia. In terzo luogo, chi non è consapevole delle proprie ferite potrebbe assumere il ruolo della persona che si prenderà cura delle ferite altrui con un atteggiamento salvifico e inconsciamente volto a curare più se stesso.
 Oltre la consapevolezza delle ferite
Oltre la consapevolezza delle ferite
Non è sufficiente mettersi in contatto con le proprie ferite, poiché occorre fare un passo successivo: trasformarle in forza rigeneratrice, aprendosi alla dimensione della riconciliazione con il proprio passato. Ad esempio, se è vero che “solo un medico ferito può prendersi cura dei propri pazienti” (Jung) è anche vero che egli deve conoscere la strada della guarigione per soccorrere la fragilità altrui. Nessuno può aiutarci se non gli comunichiamo dove siamo, in quali territori ci siamo persi o rifugiati, per difenderci dalle raffiche di solitudine o di violenza che si sono abbattuti su di noi. Aspettarsi una guarigione senza entrare in contatto con la malattia è come decidere di dimagrire senza mettersi in contatto con lo stato psicologico che origina la voracità alimentare. Quando gli occhi si inumidiscono di una pioggia di lacrime pronte a salpare per i mari della sofferenza passata, siamo pronti per il viaggio del ritorno a casa con cui ravvivare d’aria fresca e pulita la bellezza dell’essere finalmente liberi.
Il processo di guarigione
«La mia casa dice: non lasciarmi, perché qui abita il tuo passato”, e la strada mi dice:”vieni e seguimi: sono il tuo futuro”». (K. Gibran)
Accettare le proprie ferite è un primo punto del processo di guarigione. Desiderare di mettere ordine dentro di sé mette in moto il processo stesso della guarigione. Ogni volta che si cade si ha l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo su se stessi. Rimarginare le proprie ferite è un processo costellato da tutta una serie coraggiose azioni volte a dare del nostro meglio a noi stessi e al prossimo. Ad ogni ferita che si cicatrizza segue sempre un successivo momento di crescita che ci rende più forti e flessibili nell’affrontare le nuove esperienze.
«Mitologie e religioni di quasi tutte le culture sono ricche di figure che, per poter aiutare gli altri, devono prima curare se stesse»[1]. Il libro di Isaia racconta quanto segue: «Egli ha portato i nostri affanni, si è addossato i nostri dolori e noi lo abbiamo ritenuto come un castigato, un percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il nostro castigo si abbatté su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti» (Is. 53, 4-5). L’esperienza di dolore non necessariamente chiude le porte della gioia: «Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza» (Is. 53, 11). Da dove deriva la vera gioia? Dall’amore e dalla conoscenza, cioè dalla verità che tutto illumina e schiarisce. Anche le nebbie più fitte, una volta attraversata la tempesta del dolore, si dileguano per lasciare spazio a quel senso di ritrovata armonia e pace interiore. Dove c’è una ferita c’è sempre un potere di guarigione! La ferita è l’inevitabile passaggio per l’evoluzione verso una coscienza dei “valori primari“, che dovrebbero orientare il cammino dell’uomo. La guarigione è il necessario processo della vita che si rinnova e che volge il suo sguardo verso i viali della speranza, della creatività e dell’amore. Nella via della ferita rimane sempre aperto il cammino della guarigione. Sta a noi saperlo intraprendere con la piena fiducia di poter ricevere vividi colori e freschi profumi.
 Nel Vangelo di Giovanni (5, 1-4) si parla della piscina di Bethseda e della sua acqua che sanava ogni volta che veniva mossa dall’angelo del Signore. Il testo racconta di un medico che si recava periodicamente a tale piscina, aspettando l’angelo nella speranza di essere il primo a scendere nell’acqua per essere guarito dalla sua sofferenza, fatta di malinconia e di rimorsi. L’angelo appare, ma blocca il medico che è sul punto di scendere nella piscina, dicendogli che non è ancora giunto il suo momento. Alle insistenze del medico l’angelo risponde che egli non è chiamato ad essere guarito e così spiega: “Senza le tue ferite dove sarebbe il tuo potere? E’ la tua malinconia che fa vibrare la tua voce sommessa nel cuore degli uomini. Neanche gli stessi angeli del cielo possono persuadere gli infelici della terra quanto un essere umano ferito nell’ingranaggio della vita”. Un po’ più tardi, colui che era stato guarito al suo posto si avvicinò al medico, dicendogli: “Vieni con me, a casa mia, solo per un’ora. Mio figlio è perso in pensieri oscuri. Io non riesco a capirlo; solo tu sei riuscito a sollevare il suo morale. Mia figlia, dopo la morte del suo bambino, giace nell’ombra della depressione. Ella non mi ascolta, ma certamente presterà attenzione a te”. Questo racconto ci insegna che le ferite non sono una forza unicamente distruttiva se vengono riconosciute, accettate, trasformate e redente dalla nostra capacità di amare e di andare oltre il dolore. Il granaio della sofferenza va consapevolmente bruciato per lasciare spazio alla vastità del cielo acceso di lucenti stelle, mentre dei raggi di luna bianca soffici come la neve custodiscono il segreto del potente spettacolo di una nuova vita. Ecco perchè, se saggiamente vissuta, la sofferenza che possiamo provare diventa il dono della vulnerabilità.
Nel Vangelo di Giovanni (5, 1-4) si parla della piscina di Bethseda e della sua acqua che sanava ogni volta che veniva mossa dall’angelo del Signore. Il testo racconta di un medico che si recava periodicamente a tale piscina, aspettando l’angelo nella speranza di essere il primo a scendere nell’acqua per essere guarito dalla sua sofferenza, fatta di malinconia e di rimorsi. L’angelo appare, ma blocca il medico che è sul punto di scendere nella piscina, dicendogli che non è ancora giunto il suo momento. Alle insistenze del medico l’angelo risponde che egli non è chiamato ad essere guarito e così spiega: “Senza le tue ferite dove sarebbe il tuo potere? E’ la tua malinconia che fa vibrare la tua voce sommessa nel cuore degli uomini. Neanche gli stessi angeli del cielo possono persuadere gli infelici della terra quanto un essere umano ferito nell’ingranaggio della vita”. Un po’ più tardi, colui che era stato guarito al suo posto si avvicinò al medico, dicendogli: “Vieni con me, a casa mia, solo per un’ora. Mio figlio è perso in pensieri oscuri. Io non riesco a capirlo; solo tu sei riuscito a sollevare il suo morale. Mia figlia, dopo la morte del suo bambino, giace nell’ombra della depressione. Ella non mi ascolta, ma certamente presterà attenzione a te”. Questo racconto ci insegna che le ferite non sono una forza unicamente distruttiva se vengono riconosciute, accettate, trasformate e redente dalla nostra capacità di amare e di andare oltre il dolore. Il granaio della sofferenza va consapevolmente bruciato per lasciare spazio alla vastità del cielo acceso di lucenti stelle, mentre dei raggi di luna bianca soffici come la neve custodiscono il segreto del potente spettacolo di una nuova vita. Ecco perchè, se saggiamente vissuta, la sofferenza che possiamo provare diventa il dono della vulnerabilità.
[1] Maeder Th., Il guaritore ferito, in “Psicologia contemporanea”, 92 (1990), p.7.